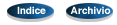
M.D.
numero 20, 6 giugno 2007
Rassegna
Nuovi fattori di rischio cardiovascolare
di Maria Cristina Ribaudo, Fausta Micheletta, Giuseppe Rosano
- Dipartimento di Scienze Mediche, Centro di ricerca clinica
e di base, Unità di Ricerca Cardiovascolare, IRCCS
San Raffaele, Roma
I fattori di rischio classici (iperlipidemia, ipertensione
arteriosa, diabete, fumo, sedentarietà, obesità)
sono oggi affiancati dalla sindrome metabolica e da una serie
di marker specifici quali Lp(a), omocisteina, proteina C reattiva,
adiponectina. Tali “nuovi” indicatori sembrano essere
correlati con lo sviluppo di eventi cardiovascolari, ma i
dati della letteratura non sono sempre concordanti
Le
malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa
di morte. Mentre la mortalità per patologia cardiache
e cardiovascolari è in diminuzione nel sesso maschile,
nelle donne si osserva un costante aumento di incidenza dall’inizio
degli anni Ottanta. Ciò è dovuto in parte alla
crescita della popolazione femminile in menopausa e in parte
per l’avere considerato i fattori di rischio cardiovascolare
equipollenti nei due sessi.
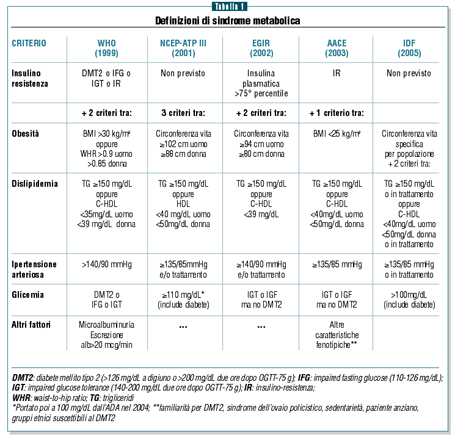 Oggi
è chiaro che mentre negli uomini elevati valori di colesterolo
totale e C-LDL rappresentano il principale fattore di rischio,
nelle donne - sempre per patologia vascolare - il diabete mellito
e gli aumentati valori pressori hanno un’importanza maggiore
nel determinare eventi cardiovascolari. Per di più nelle
donne l’associazione ipertensione arteriosa-diabete mellito
conferisce un aumento del rischio cardiovascolare doppio rispetto
agli uomini. Oggi
è chiaro che mentre negli uomini elevati valori di colesterolo
totale e C-LDL rappresentano il principale fattore di rischio,
nelle donne - sempre per patologia vascolare - il diabete mellito
e gli aumentati valori pressori hanno un’importanza maggiore
nel determinare eventi cardiovascolari. Per di più nelle
donne l’associazione ipertensione arteriosa-diabete mellito
conferisce un aumento del rischio cardiovascolare doppio rispetto
agli uomini.
Le evidenze che i fattori di rischio tendono ad associarsi nello
stesso paziente e che spesso ipertensione arteriosa e turbe
del metabolismo glucidico hanno fattori patogenetici comuni
ha portato alla definizione di un corteo sindromico noto come
sindrome metabolica.
Sindrome metabolica
La sindrome metabolica è una condizione clinica caratterizzata
dalla presenza concomitante di molteplici fattori di rischio
quali obesità addominale, insulino resistenza (con o
senza alterazioni glicemiche), dislipidemia, ipertensione arteriosa,
stato procoagulativo e proinfiammatorio che svolgono un ruolo
fisiopatologico importante nello sviluppo di malattie cardiovascolari.
Le definizioni proposte sono state numerose (tabella 1):
-
WHO
1999 (World Health Organization);
-
NCEP-ATPIII
2001 (Third Report of The National Cholesterol Education Expert
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood
Cholesterol In Adults - Adult Treatment Panel III);
-
EGIR
2002 (European Group For The Study of Insulin Resistance);
-
AACE
2003 (American Association of Clinical Endocrinologists);
-
IDF
2005 (International Diabetes Federation).
A
tutt’oggi però non si è ancora giunti a una
definizione univoca del complesso quadro patologico in esame,
sebbene la proposta del 2001 sembrerebbe quella più facilmente
applicabile nella pratica clinica.
Gli studi
Diversi studi osservazionali hanno dimostrato che la sindrome
metabolica determina un aumento pari a circa 2 volte il rischio
di sviluppare eventi cardiovascolari e pari a circa 5 volte
quello di nuova insorgenza di diabete mellito. Tale rischio
aumenta in modo progressivo e lineare in relazione al numero
degli elementi caratterizzanti la sindrome presenti nel singolo
paziente.
-
Una
delle prime dimostrazioni della correlazione tra numero di
fattori di rischio e mortalità cardiovascolare è
stata fornita dal “Multiple Risk Factor Intervention
Trial”, che ha dimostrato che un numero crescente di
fattori sia associato a un crescente rischio di mortalità
vascolare, rischio da 3 a 4 volte maggiore in presenza di
diabete.
-
Il
Botnia Study ha dimostrato che tra i vari fattori di rischio
solo la dislipidemia (ipertrigliceridemia e/o bassi livelli
di C-HDL) era correlata con la cardiopatia ischemica, mentre
la sindrome metabolica (valutata con i criteri WHO) correlava
significativamente non solo con la cardiopatia ischemica,
ma anche con l’infarto del miocardio e con l’ictus
cerebri.
-
Lo
studio DECODE ha dimostrato che la prevalenza della sindrome
metabolica (valutata con i criteri WHO lievemente modificati)
risultava lievemente superiore negli uomini rispetto alle
donne e globalmente si aggirava intorno al 15% della popolazione
studiata. La mortalità generale nei soggetti con sindrome
metabolica era 2.26 volte superiore negli uomini e 2.78 volte
superiore nelle donne rispetto ai soggetti senza sindrome
dopo aver corretto per età, fumo e ipercolesterolemia.
Inoltre nei pazienti con ipertensione e diabete il rischio
era di 2.5 per gli uomini e 4.8 per le donne.
-
Lo
studio ARIC ha riscontrato che la sindrome metabolica diagnosticata
con i criteri ATP III era presente nel 28% degli uomini e
nel 34% delle donne. Durante 11 anni di follow-up l’aumento
del rischio di cardiopatia ischemica associato a sindrome
metabolica era 1.7 volte superiore negli uomini e 2.6 volte
nelle donne con la sindrome.
-
Una
metanalisi pubblicata nel 2006 ha confrontato 21 studi che
esaminavano l’associazione tra sindrome metabolica e
rischio cardiovascolare. I risultati hanno confermato un incremento
del 35% della mortalità per tutte le cause, del 53%
per patologie cardiovascolari del 52% per patologia coronarica
e del 76% per ictus cerebri. Il rischio relativo di patologie
cardiovascolari associato alla sindrome metabolica risultava
più elevato nelle donne rispetto agli uomini e più
elevato negli studi che avevano usato i criteri WHO per definire
la sindrome metabolica rispetto agli studi che avevano utilizzato
i criteri ATP III.
-
Questi
dati sono stati confermati da una recente metanalisi (nella
quale sono stati valutati 37 studi longitudinali, dal 1971
al 1997) che includevano 172.573 soggetti. Lo studio ha evidenziato
che la sindrome metabolica
determina un aumento del rischio di eventi cardiovascolari
e di morte del 78%. Tale aumento del rischio era più
evidente nelle donne (63% vs 78%), inoltre il rischio era
maggiore nel sesso femminile negli studi in cui erano stati
arruolati soggetti con rischio minore (<10%), e negli studi
che avevano usato i criteri WHO per definire la sindrome metabolica
(RR 2.68 e 2.06 vs 1.67 con i criteri NCEP e 1.35 con altri
criteri, p= 0.005).
Da
quanto enunciato è evidente che, nonostante limiti e non
uniformità di criteri adottati per la definizione di sindrome
metabolica, è estremamente importante identificare i
soggetti affetti, al fine di attuare un intervento di prevenzione
delle complicanze cardiovascolari e in generale per ridurre la
morbilità e la mortalità.
Obiettivo terapeutico
L’obiettivo terapeutico della sindrome metabolica deve essere
indubbiamente orientato in primo luogo alla riduzione dei fattori
ambientali (obesità, sedentarietà, ecc) oltre che
al trattamento dei fattori di rischio per aterosclerosi, trombosi
e malattie cardiovascolari.
L’evidenza scientifica ha da tempo indicato come una corretta
alimentazione e una costante attività fisica determinino
un netto miglioramento di molti parametri associati ad aumentato
rischio cardiovascolare come l’assetto lipidico, l’insulino-resistenza,
i livelli di pressione arteriosa, l’eccesso di tessuto adiposo.
Lo studio FinRisk ha dimostrato che un programma di riabilitazione
fisica e dieta riduce il rischio di diabete mellito di circa il
50% nelle donne con sindrome metabolica.
Inoltre dati dell’ATP III dimostrano come la riduzione pressoria
sia più importante nelle donne che negli uomini. Infatti
la riduzione delle pressione arteriosa a livelli ottimali (135
mmHg sistolica) o ideali (120 mmHg sistolica) induce una stessa
riduzione del rischio cardiovascolare negli uomini, mentre nelle
donne la strategia più aggressiva riduce significativamente
di più il rischio.
È importante notare che la modificazione del rischio cardiovascolare
che avviene dopo la menopausa è multifattoriale e dovuta
alla riduzione dei livelli degli ormoni sessuali. Tale riduzione
ormonale causa un aumento dei valori pressori e del colesterolo,
ma anche un aumento di peso con una redistribuzione del grasso
che da ginoide diviene androide.
L’aumento dell’adiposità addominale nelle donne
facilita lo sviluppo di diabete e ipertensione arteriosa. Pertanto
l’obesità addominale rappresenta un importante fattore
di rischio modificabile nel sesso femminile che necessita di un
intervento precoce soprattutto nei primi anni dopo la menopausa.
Adiponectina
Il tessuto adiposo, una volta considerato come un sito inerte
di deposito di substrati energetici, ha assunto negli ultimi anni
un’importanza rilevante come organo endocrino che rilascia
ormoni nel sangue e che prende parte direttamente allo sviluppo
di insulino-resistenza, obesità e diabete. I principali
ormoni prodotti dal tessuto adiposo sono l’adiponectina,
la leptina, la resistina.
L’adiponectina, proteina plasmatica prodotta esclusivamente
da adipociti, agisce prevalentemente nel muscolo e nel fegato
dove svolge un’azione insulino-sensibilizzante e antidiabetogena.
A livello epatico inibisce l’espressione di alcuni enzimi
della gluconeogenesi e a livello muscolare aumenta il trasporto
di glucosio e l’ossidazione di acidi grassi.
Nei pazienti obesi diabetici i livelli di adiponectina sono significativamente
ridotti. Essa migliora la sensibilità insulinica in tutto
l’organismo, facendo ipotizzare che i bassi livelli di questo
ormone nei diabetici di tipo 2 siano una delle cause di insulino-resistenza.
Numerosi studi sull’uomo hanno dimostrato come ridotti livelli
di adiponectina siano associati ad aumento del Body Mass Index
(BMI), riduzione della sensibilità insulinica, alterazioni
del quadro lipidico, aumento dei marker infiammatori e del rischio
cardiovascolare, aumento di incidenza di infarto miocardio e progressione
della malattia coronarica.
Omocisteina
L’omocisteina è un aminoacido sulfidrilico che deriva
dalla conversione metabolica dell’aminoacido essenziale metionina.
Un incremento dei livelli plasmatici di omocisteina si può
riscontrare in soggetti con difetti genetici, alterazioni acquisite
o più spesso una combinazione delle due condizioni.
Negli ultimi due decenni sono state fornite molte evidenze scientifiche
a favore di un possibile ruolo dell’iperomocisteinemia lieve-moderata
(da 15 a 100 mmol/l), quale fattore di rischio per patologie cardiovascolari
con particolare riferimento alla malattia aterotrombotica.
Numerosi studi retrospettivi caso-controllo hanno dimostrato l’associazione
tra iperomocisteinemia e malattie cardiovascolari, in particolare
malattia coronarica, cerebrovascolare e arteriosa periferica.
I risultati di tali studi sono stati analizzati in una metanalisi
che ha mostrato un significativo aumento del rischio relativo
di coronaropatia (RR 1.7, 95% CI 1.5-1.9), di patologia cerebrovascolare
(RR 2.5, 95% CI 2.0-3.0) e di arteriopatia obliterante periferica
(RR 6.8, 95% CI 2.9-15.8) in soggetti con elevati livelli plasmatici
di omocisteina.
Contrariamente a ciò, i risultati forniti dagli studi prospettici,
che hanno valutato la relazione tra omocisteinemia e rischio di
malattia cardiovascolare in soggetti sani al momento dell’arruolamento,
hanno mostrato una meno chiara e meno forte associazione tra iperomocisteinemia
e patologia cardiovascolare. Infatti, dopo aggiustamento per fattori
di rischio maggiori, l’iperomocisteinemia è risultata
un modesto predittore indipendente di cardiopatia ischemica e
ictus nella popolazione sana.
I dati preliminari forniti dagli studi caso-controllo e prospettici
non hanno al momento trovato conferma nei primi trial clinici,
randomizzati e controllati con placebo, sull’effetto della
supplementazione vitaminica. Infatti, la supplementazione con
acido folico associato o meno a vitamine del gruppo B non è
stata in grado di ridurre la ricorrenza di eventi vascolari maggiori
in tre diverse popolazioni di pazienti con malattia vascolare
(recente IMA, recente ictus ischemico e pazienti con diabete mellito
e alto rischio cardiovascolare) nonostante la riduzione dei livelli
plasmatici di omocisteina.
Proteina C reattiva
La proteina C reattiva (PCR) è una proteina di fase acuta,
che è stata dimostrata essere un affidabile marcatore di
infiammazione sistemica.
Sebbene i livelli di PCR aumentino drasticamente in risposta a
processi infettivi maggiori o a traumi, nei soggetti asintomatici
le concentrazioni plasmatiche di PCR sono molto stabili nel lungo
termine. Per tale motivo e sulla base dell’ipotesi infiammatoria
dell’aterosclerosi la PCR è stata studiata in varie
popolazioni di pazienti affetti o a rischio di malattia cardiovascolare,
ed è stata infine proposta quale nuovo fattore di rischio
cardiovascolare.
Numerosi studi epidemiologici prospettici (spesso provenienti
dallo stesso gruppo che detiene la royalties per la PCR ad alta
sensibilità) hanno dimostrato che i livelli di PCR hanno
un elevato valore predittivo a lungo termine per il verificarsi
di eventi cardiovascolari (infarto miocardico, ictus cerebrale
e sviluppo di arteriopatia periferica clinicamente manifesta)
indipendentemente dai livelli di C-LDL e dalla classe di rischio
cardiovascolare.
Nel 2003 il Center for Disease Control (CDC) e l’American
Heart Association (AHA) hanno prodotto le prime linee guida che
propongono l’utilizzo della PCR quale fattore di rischio,
in aggiunta ai fattori tradizionali, per lo screening cardiovascolare.
Sulla base dei dati disponibili in letteratura sono stati stabiliti
dei valori di PCR in base ai quali definire il rischio cardiovascolare
del paziente: livelli <1 mg/L identificano un basso rischio,
valori compresi tra 1 e 3 mg/L un rischio intermedio e valori
>3 mg/L un alto rischio. Tuttavia tali valori non sono standardizzati
e mancano valori di normalità per la popolazione europea.
Sebbene i numerosi dati forniti dagli studi sulla PCR e le malattie
aterosclerotiche cardiovascolari fanno di questo marcatore di
infiammazione un potenziale nuovo fattore di rischio cardiovascolare
da utilizzare nella pratica clinica, per la stratificazione del
rischio l’utilizzo della PCR è di scarsa rilevanza
quando aggiunto al calcolo del rischio cardiovascolare effettuato
con il metodo europeo (SCORE).
Lipoproteina(a)
Elevati livelli plasmatici di lipoproteina(a) - Lp(a) - sembrano
essere associati a un aumentato rischio di malattia cardiovascolare
indipendentemente dall’associazione con altre alterazioni
del profilo lipidico e fattori di rischio noti. La Lp(a) è
una lipoproteina ricca di colesterolo che presenta similarità
strutturali con le LDL, dalle quali si differenzia per la presenza
dell’apolipoproteina(a) - ApoA.
L’apolipoproteina(a) presenta una notevole omologia strutturale
con il plasminogeno, con il quale sembra condividere un effetto
protrombotico eventualmente responsabile dell’associazione
tra Lp(a) ed eventi cardiovascolari in vivo.
Una recente metanalisi ha analizzato i risultati di 27 studi prospettici
che hanno riportato la correlazione tra livelli plasmatici di
Lp(a) ed eventi cardiovascolari (mortalità per cardiopatia
ischemica e infarto miocardio non fatale).
In un periodo di follow-up medio di 10 anni sono stati complessivamente
osservati più di 5.000 casi di cardiopatia ischemica in
pazienti sani (18 studi) e con malattia cardiovascolare pre-esistente
(9 studi). Il rischio relativo di cardiopatia ischemica nei soggetti
con livelli di Lp(a) nel terzo superiore rispetto al terzo inferiore
è risultato significativamente aumentato, 1.7 (95%, CI
1.4-1.9) nella popolazione di pazienti sani e 1.3 (95%, CI 1.1-1.6)
in quella con malattia pre-esistente.
Tale associazione è stata successivamente confermata da
una grande studio prospettico che ha incluso più di 9.000
pazienti senza storia di cardiopatia ischemica e in assenza di
farmaci ipolipidemizzanti. Il rischio relativo di eventi cardiovascolari
(morte coronarica, infarto miocardico e angina pectoris) nei
soggetti con livelli di Lp(a) nel quartile più alto è
risultato 1.5 volte maggiore rispetto ai soggetti nel quartile
più basso (RR 1.56; 95% CI 1.1-2.21). Quest’ultimo
studio ha inoltre dimostrato che la presenza di elevati livelli
di Lp(a) aggrava in maniera significativa il rischio cardiovascolare
associato alla presenza di elevati livelli di LDL.
Nonostante il grande numero di evidenze fornite a favore di un
ruolo della Lp(a) quale nuovo fattore di rischio cardiovascolare,
non esistono al momento trial clinici di intervento farmacologico
in grado di chiarire un nesso di causa-effetto di tale associazione.
A questo proposito bisogna sottolineare che le concentrazioni
plasmatiche di Lp(a) aumentano in menopausa e sono poco modificabili
dalla dieta, dall’attività fisica e dai farmaci ipolipidemizzanti
a disposizione, fatta eccezione per la niacina e la terapia ormonale
sostitutiva. Infatti, studi caso-controllo e studi osservazionali
longitudinali hanno indicato che la terapia ormonale sostitutiva
è in grado di ridurre i livelli plasmatici di lipoproteina(a)
dal 10% al 50%. Questa osservazione è stata supportata
da un recente trial clinico randomizzato e controllato con placebo
(PEPI study) nel quale i livelli di Lp(a) sono stati valutati
dopo 12 e 36 mesi di terapia estroprogestinica. La terapia ormonale
si è dimostrata in grado di ridurre in maniera significativa
i livelli di Lp(a) rispetto al placebo (17-29%).
Analoghi risultati sono stati forniti da una sottoanalisi dello
studio HERS (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) nel
quale si è visto che aumentati livelli di Lp(a) sono un
predittore di rischio indipendente per ricorrenza di malattia
cardiovascolare nelle donne in menopausa, e che il trattamento
con estroprogestinici è in grado di ridurne in maniera
significativa i livelli plasmatici rispetto al placebo.
Conclusioni
In base a quanto riportato si può concludere che la prevenzione
della patologia cardiovascolare è ottenibile con un’adeguata
modificazione dello stile di vita e con un trattamento intensivo
di tutte le componenti della sindrome metabolica.
È sicuramente importante tenere in considerazione i nuovi
fattori di rischio nella stratificazione del rischio cardiovascolare
in ogni singolo paziente considerando il differente impatto che
hanno nei due sessi.
Per quanto riguarda i nuovi marcatori quali adiponectina, lipoproteina
(a), omocisteina, proteina C reattiva, mancano o sono discordanti
dati di efficacia di prevenzione primaria o secondaria forniti
da studi clinici d’intervento randomizzati e controllati
con placebo.
|